El Camino – Un Passo Indietro, Poi Sempre Avanti
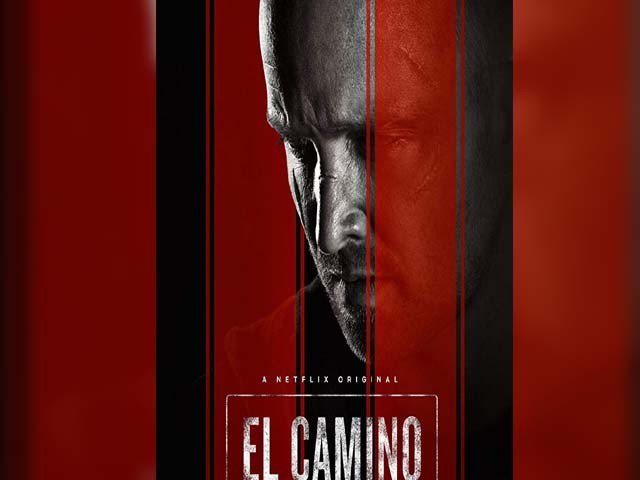
Io me la ricordo Battle Creek.
Era il Marzo del 2015 e mi ero appena laureato con una tesi su Breaking Bad. Verso Vince Gilligan ed i suoi progetti avevo finito per sviluppare un sentimento ambivalente: una parte di me lo odiava, perché lo considerava la causa prima di un lavoro (la tesi) che era andato a buon fine ma che, data la vastità della materia era cresciuto esponenzialmente e si era complicato al di là del mio controllo, rischiando, spesso, di schiacciarmi sotto al suo peso; la mia parte irrazionale, al contrario, non poteva fare a meno di ammirarlo. Lui, il suo stile di scrittura, la maniera in cui aveva saputo coniugare iperealismo, postmodernità e cinema di genere in quel Breaking Bad che è, ad oggi, il suo Opus Magnum. Io me la ricordo Battle Creek.

Battle Creek avrebbe dovuto essere il primo progetto post Breaking Bad di Vince Gilligan, che per l’occasione ha unito le forze con quel David Shore che era stato il papà di House M.D. Due dei creativi più influenti dell’intrattenimento televisivo contemporaneo uniti in un nuovo progetto di genere, un racconto della provincia americana dal punto di vista di due granitici agenti delle forze di polizia impegnati a combattere il crimine organizzato di stampo rurale. I media specializzati non parlavano d’altro e l’hype si tagliava con il coltello, alimentato dalle speculazioni di spettatori e appassionati che già si immaginavano di confrontarsi con un prodotto che avrebbe coniugato, magari, l’attenzione alla scrittura dei personaggi di David Shore e la cura per le atmosfere della provincia americana e per il genere di Vince Gilligan.
Non accadde, tuttavia, nulla di tutto questo. Battle Creek si rivelò un buddy movie diluito per renderlo una serie tv. Un fiacco progetto tutto giocato sulla comicità fuori luogo nata dal contrasto tra i due agenti protagonisti, una serie che, inspiegabilmente, piuttosto che trovare una sua anima nella cifra stilistica dei suoi due autori tenta con tutta se stessa di scimmiottare la scrittura di Shane Black e del suo Lethal Weapon. Battle Creek venne di fatto chiuso dopo tre puntate per bassi ascolti, la rete accettò di trasmettere gli episodi restanti ma non rinnovò, prevedibilmente, né la serie né il contratto dei due autori.

Io me la ricordo Battle Creek e mi ricordo, anche, la portata della bolla legata all’orizzonte d’attesa dello spettatore che finì per esplodere nel momento in cui egli si confrontò con quello che, a tutti gli effetti, sembra, a posteriori, uno dei più maldestri bluff della storia dell’intrattenimento contemporaneo.
Soprattutto, però, mi ricordo le conseguenze che il fallimento di Battle Creek causò a Vince Gilligan.
A ben guardare, la vicenda Battle Creek finì facilmente insabbiata da un altro progetto di Gilligan, stavolta in collaborazione con Peter Gould, lanciato praticamente in contemporanea ad esso (siamo nel Febbraio del 2015): Better Call Saul.
Quando io, personalmente, mi trovai a scrivere di Better Call Saul mi colpì in particolare l’atmosfera calorosa, a suo modo accogliente, che trasmetteva la serie allo spettatore. Era una lettura diversa, certamente, come ho detto io stesso, straniante, inattesa, dell’universo di Breaking Bad ma, dopo l’impatto iniziale, era indubbiamente (e comunque) “casa”, una casa dove forse è stato appena spostato qualche mobile, uno spazio nuovamente arredato, ma che non ha perso, malgrado il restyling, il suo carattere di rifugio sicuro, per noi, senz’altro, ma, ora, a posteriori, dopo El Camino, anche e soprattutto per Vince Gilligan.

Perché Vince Gilligan, dopo il botto di Battle Creek, sembra essere entrato in crisi, impaurito ad organizzare da zero qualcosa di diverso, qualcosa di lontano dal suo universo narrativo di maggior successo, una dimensione che tuttavia Gilligan, quasi in imbarazzo per questa sorta di esilio creativo autoimposto, tiene a distanza, preferendo lavorare sul prequel della sua creatura più amata, piuttosto che tornare a sporcarsi le mani con il racconto di Walt e Jesse, nascondendosi dietro alla sicurezza di aver chiuso la storyline principale nel modo migliore.
E allora, in questa prospettiva, cos’è, davvero, El Camino?
Più facile, forse, è prendere atto di cosa, quello che è stato pubblicizzato il “Film Di Breaking Bad”, non è, partire da lì e vedere dove arriviamo.
Di sicuro non è, per quanto tutti si sforzano di dire il contrario, il “Film Sequel” della serie principale: El Camino è, piuttosto, il lato B delle ultime due o tre puntate di Breaking Bad, la “Versione di Jesse” dell’epilogo di quell’assurda epopea che ha condiviso con Walt (pensiamo agli splendidi flashback che qui raccontano la sua prigionia ed approfondiscono il rapporto con Todd) a cui segue una lunga coda utile a chiudere il suo arco ma che, sia chiaro, non espande in alcun modo il racconto vero e proprio così come era stato concepito da Gilligan fino al 2013.

Da un certo punto di vista non è neanche un film che, come si è detto, è stato concepito solo per chi ha visto la serie nella sua interezza né un progetto zeppo di fanservice destinato a fare leva sul portato sentimentale degli spettatori più affezionati. Le radici narrative di El Camino non affondano così profondamente nella mitologia di Breaking Bad e, anzi, se è senz’altro consigliabile aver visto tutta la serie prima di approcciare il film, lo spettatore più pigro potrebbe benissimo vedersi le ultime quattro puntate, facendosi raccontare il resto da un amico volenteroso e la sua esperienza di visione non verrebbe mutilata in maniera così grave come ci si potrebbe aspettare.
Al contempo, se è vero che spunti legati all’orizzonte del fanservice puntellano alcuni snodi del racconto (pensiamo all’inizio, alla fine, pensiamo, anche, alla presenza di Robert Forster, complice anche il cortocircuito che ha voluto che l’attore finisse i suoi giorni terreni in contemporanea con la premiere del film), non si nota mai la volontà, da parte di Gilligan, di calcare troppo la mano sul versante sentimentale del rapporto tra opera e fruitore. Non si assiste, in sostanza, a quell’azione di semina, raccolta e premio che, per dire, porta a disseminare la Marvel a disseminare i suoi film di riferimenti al suo universo narrativo che solo i più attenti riescono a cogliere, anzi, da un certo punto di vista, a Vince Gilligan, del nostro coinvolgimento all’interno della vicenda, interessa ben poco.
El Camino è, a ben guardare, uno di quei rari casi di prodotto che, solo incidentalmente è pensato come un’opera adatta alla fruizione di un pubblico di spettatori o che comunque non fa dell’appagamento di chi guarda il suo fine ultimo.
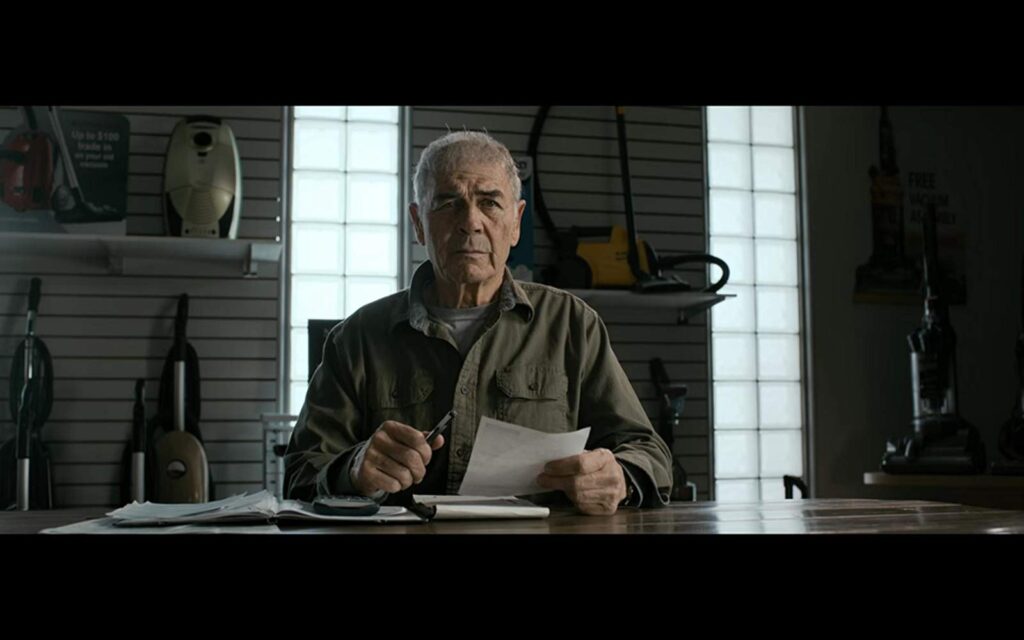
El Camino è, piuttosto, il frutto della seduta psicoanalitica attraverso la quale Vince Gilligan prova a fare pace con la sua creatura e a riscoprire quella sicurezza dell’atto creativo che da qualche anno sembra mancargli. Si parte da una storia, legata abbastanza al racconto principale da stimolare l’interesse del pubblico ma al contempo dotata di quell’indipendenza narrativa necessaria a non chiudere l’autore in una gabbia troppo stretta; ci si sposta poi, a studiare il formato più adatto a questa storia, che nel caso di El Camino è quello del film televisivo da due ore, adatto, prima che agli standard di Netflix, ad un confronto per certi versi controllato con la propria creatura, che non obbliga Gilligan ad un’immersione totale, completa, in un mondo con cui non riesce più a venire a patti. In ultimo, si riflette sul primo ingranaggio del meccanismo, il protagonista, che nel caso di El Camino è Jesse Pinkman come si diceva. È questa, di fatto la scelta più logica, non solo perché Jesse è l’unico a non avere ancora ricevuto un epilogo alla sua storia, a differenza di Walt e addirittura di Saul (che in alcuni brevissimi frangenti della sua serie prequel vediamo muoversi ed agire proprio nel mondo post Breaking Bad), ma, anche e soprattutto, perché forse non c’è nessuno più adatto di Aaron Paul a tornare, insieme a Gilligan, in quei territori minacciosi e affascinanti che i due avevano giurato di abbandonare cinque anni fa.
Perché Vince Gilligan ed Aaron Paul sono, di fatto, molto più simili di quanto entrambi vogliano ammettere. Per entrambi Breaking Bad è stato il punto di svolta ma anche un momento di crisi delle loro carriere.

Li ha colti impreparati, è stato un evento imprevisto estremamente positivo che però, di fatto, ha tagliato ad entrambi le gambe in termini professionali. Se Vince Gilligan non ha prodotto più nulla di significativo all’infuori del franchise di Breaking Bad, Aaron Paul è in effetti finito in un limbo artistico che l’ha portato ad interpretare discutibili ruoli nati sulla scia della caratterizzazione di Jesse Pinkman senza però la forza dell’assistente di Walter White e da cui, con buona probabilità, uscirà solo nei prossimi mesi grazie al Westworld di HBO.
Ecco dunque, cos’è, nel profondo, El Camino, una terapia di gruppo per due, una Folie A Deux in cui due artisti provano, lentamente, ad organizzare un confronto proficuo con la loro creatura dopo averne evitato lo sguardo per anni.
In fondo, è arrivato il momento, vuoi anche perché Vince Gilligan è giunto quasi alla fine del suo cammino con Better Call Saul, una serie che, tra l’altro, paradossalmente, nel suo voler tenere le distanze dalla saga maggiore ha finito, con il tempo, con il passare delle stagioni, con l’assomigliarli pericolosamente. Ormai né lui né Aaron Paul possono più scappare, è il momento di affrontare i propri demoni una volta per tutte.

Ed in effetti, a ben guardare, lo sviluppo di El Camino, il modo in cui è organizzato non solo il racconto ma anche le vere e proprie linee tematiche, porta con sé quella volontà di fare ordine dal caos tipica delle sedute psicoanalitiche.
Si parte dall’entropia pura, dall’ostilità più profonda della creatura nei confronti dei loro creatori.
Il racconto riprende dalla fuga di Jesse e dunque si porta in primo piano un’istanza traumatica che non è così assurdo ricondurre (anche) al puro trauma che la saga ha indirettamente causato nell’interiorità di Vince Gilligan ed Aaron Paul.
Si inizia con il dolore, con l’incertezza, con il dubbio, narrativo ma anche creativo, che viene portato all’attenzione di chi guarda dapprima in tutta la sua evidenza (complice anche il contrasto con il placido prologo dialogato tra Jesse e Mike) e poi, centellinato in uno stillicidio angosciante che aggredisce lo spettatore in maniera improvvisa attraverso i flashback conseguenti allo stress post-traumatico di Jesse.
Subito dopo, tuttavia, man mano che la narrazione si approfondisce, entra nel vivo, la negoziazione messa in campo da Vince Gilligan finisce per prendere strade impreviste. C’è una strana delicatezza, nel racconto della fuga verso la sua nuova vita di Jesse Pinkman, un inaspettato ma persistente ottimismo, caratterizza il suo cammino alla ricerca della libertà.
Qualcuno potrebbe dire (e non è detto che non sia vero), che Gilligan desidera regalare un happy end magari irrealistico ma straordinariamente sentito al personaggio che, di fatto, ha affrontato il calvario più grande all’interno del suo arco ma, per certi versi, accontentarsi di questa spiegazione significherebbe fermarsi alla punta dell’iceberg.
La delicatezza, la calma, meglio ancora, la sapiente costruzione dell’intreccio, che scorre placido, affronta determinati (fors’anche prevedibili) picchi e poi monta in un climax che risolve tutte le tensioni precedenti e dunque l’accettazione di un’organizzazione del racconto tradizionale, addirittura troppo, pensando all’approccio tipico di Vince Gilligan, è al servizio della funzione terapeutica che sottende ad El Camino.
Gilligan ha bisogno di tornare per gradi a “masticare” la sintassi scenica, la pura scrittura di Breaking Bad, una necessità che investe anche il rapporto tra Aaron Paul ed il suo personaggio.

El Camino è un diesel proprio per questo. Inizia piano, si sviluppa con i suoi tempi, quasi come fosse una creatura viva che dovesse imparare a camminare per una seconda volta. Attraverso fasi definite si rifà ordine nell’universo narrativo (anche attraverso i flashback di Jesse con Todd), si ricrea equilibrio, ma soprattutto si attraversa nuovamente l’universo di Breaking Bad, contaminando, ad esempio, la narrazione con situazioni tipiche della cifra della serie, oppure permettendo ad Aaron Paul di ritrovare in sé i tratti, l’astuzia, l’istinto autodistruttivo, del Jesse Pinkman che in realtà è sempre stato parte di lui e che l’attore deve tornare a percepire come entità straordinariamente positiva sul piano creativo, piuttosto che minaccia da estirpare, o al contempo arrivando ad mettere in scena una sorta di sequenza inedita della seconda stagione che funziona, anche e soprattutto, come un confronto, che è anche un commiato definitivo, da parte, di Gilligan e Paul con i due protagonisti della saga.
Poi, però, se da un lato al trauma si è dato finalmente ordine, dall’altro non si può fare a meno di attraversarlo. Dopotutto è solo affrontando di peso le proprie paure che si può dire di averle superate.
All’interno di questa prospettiva, tutta rivolta alle menti creative alle sue spalle, El Camino è anche il punto in cui Vince Gilligan ed Aaron Paul assorbono e superano l’essenza profonda della propria creatura (per l’uno) e del proprio personaggio (per l’altro), in un costante gioco a due in cui la prima istanza influenza l’altra e viceversa.
L’evoluzione di Jesse Pinkman ed al contempo dell’idea che Aaron Paul (e noi con lui) avevamo del personaggio è forse quella più evidente. Jesse, Jesse il remissivo, Jesse il codardo, Jesse il debole, Jesse il puro, supera l’idea che ha di sé stesso e, in uno straordinario tentativo di rivalsa, abbraccia con grinta quella vendetta che, prima del desiderio del sangue indica in maniera chiara la sua piena maturazione in quanto personaggio.
Mai come in El Camino Jesse assume in sé i tratti volutamente irrealistici ma straordinariamente potenti del pistolero senza nome in cerca di rivalsa, ma, a ben guardare, mai come in El Camino, i riferimenti all’immaginario Western sono così evidenti ripensando a quanto scorrevano sottotraccia nella saga principale.
E allora, forse, è proprio qui l’azione di superamento del trauma organizzata da Vince Gilligan, un trauma che, per essere estirpato, ha bisogno di fare pace, di abbracciare completamente, la sua radice tematica, quel Western, quel racconto di frontiera che ha irrorato il racconto fin dal primo episodio della prima stagione ma che si è mosso come fiume carsico, elemento creativo tenuto a bada, salvo che in alcune occasioni particolari (pensiamo alla rapina al treno della quinta stagione).

El Camino è dunque, per Gilligan, il luogo in cui tornare a fare pace con la tradizione e con la libera elaborazione della stessa che ha caratterizzato il suo approccio. Durante il racconto si incrociano influenze da Cormac McCarthy ed Elmore Leonard, Jesse si muove come un fuorilegge ricercato che si sposta attraverso spazi che hanno in loro il germe polveroso del selvaggio West e, soprattutto, la vicenda finisce per inglobare due elementi (lo straordinario duello finale e la fuga nel profondo Nord) che sono vere e proprie strutture di significato di chiara matrice western.
Dopo due ore, forse, Vince Gilligan ed Aaron Paul hanno fatto pace con la loro creatura, ma soprattutto hanno creato un progetto che, nel suo distanziare lo spettatore, nel suo essere opera straordinariamente personale, non può fare a meno, paradossalmente, di attrarre chi guarda. Al di là di come proseguirà la carriera artistica dei due artisti, la speranza è che il sorriso liberatorio di Jesse con cui si chiude la serie, sia lo stesso sorriso che è comparso sulle labbra di Vince Gilligan ed Aaron Paul, nel momento dell’ultimo stop, soddisfatti del lavoro compiuto su di loro, prima che del loro progetto.
Alessio Baronci





